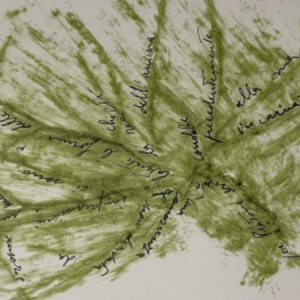Questo articolo è per stomaci forti. Per chi sa distinguere tra aspetti etici e ideologici – dove ciascuno giustamente fa le sue scelte – e consumismo indotto, false notizie, credenze e mode. Nessuno più di un genitore ascolta – spesso con apprensione – le notizie che arrivano dal mondo alimentare. La salute dei bambini è nelle nostre mani, il carrello della spesa può essere medicina o veleno, pentole e fornelli possono nascondere insidie delle quali ci pentiremo negli anni a venire. Sbagliamo? No. È umano. Fa parte del ruolo di genitore. E allora aderiamo con convinzione alle campagne contro l’olio di palma, andiamo a fare la spesa rigorosamente bio, eliminiamo il glutine e trattiamo la carne rossa come il demonio. Ma facciamo bene?
Davvero è meglio bio?
Per l’acquisto degli alimenti biologici siamo disposti a spendere anche il doppio del normale, secondo una ricerca di Altroconsumo. Lo facciamo convinti che i prodotti siano più genuini, più buoni, più rispettosi del pianeta, più nutrienti e soprattutto che non contengano residui di pesticidi. Ne siamo sicuri? Il discorso sul biologico è estremamente complesso e spesso si snoda su un piano legislativo più che medico o nutrizionale. Sono tanti i distinguo e anche ambientalisti famosi come il danese Bjorn Lomborg affermano che dal punto di vista della prevenzione delle malattie, è meglio mangiare un frutto o una verdura in più (anche se coltivati con pesticidi) piuttosto che mangiarne uno (biologico) in meno, non acquistato perché troppo costoso.
Biologico, poi, non sempre è sinonimo di sostenibile. È vero che viene favorita la rotazione delle colture (e quindi protetta la biodiversità), è vero che la normativa limita l’uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi, è vero che vieta l’allevamento intensivo con l’uso di antibiotici e ormoni. “Tuttavia non sono previsti vincoli sulla distribuzione e il commercio – scrive il CNR nel progetto Agricoltura Sostenibile -. La frutta esotica bio, per esempio, è sostenibile? Insalata e carote acquistate al mercato sono più o meno green della verdura biologica venduta in pacchetto nell’ipermercato? I calcoli sono complessi e la risposta non è univoca.
Dal punto di vista della salute, l’idea che nel bio si trovino più nutrienti non ha particolari riscontri scientifici. Esagerata appare anche la preoccupazione sui residui dei pesticidi chimici”. L’Efsa, l’organo europeo sulla sicurezza alimentare, stabilisce il limite massimo di residui riscontrabili negli alimenti; un limite precauzionale, ben inferiore al livello tossicologico accettabile. “Da questo punto di vista – assicura il CNR – l’agricoltura tradizionale è sicura e, tendenzialmente, basta sciacquare la frutta e la verdura per eliminare anche quel minimo di residuo rimasto sulla superficie”. Insomma, nel mondo green non tutto è bianco o nero e quel che sembra pesare di più è lo squilibrio tra il consumo di proteine (l’Efsa evidenzia che ne mangiamo troppe) e il consumo di frutta e verdura, che da sempre è il fanalino di coda dell’alimentazione contemporanea.
La carne rossa è cancerogena?
Sì, no, dipende. Nel 2015 la notizia bomba: il consumo di carne rossa aumenta il rischio di tumore. Colpa di uno zucchero presente nei tessuti dei mammiferi che il nostro organismo identifica come estraneo. Seguono studi, un’ampia disinformazione, poco spazio per le precisazioni. Alla fine, però, si fa retromarcia. Cosa c’è di vero? “La dieta delle persone contiene un numero quasi imponderabile di componenti diverse – dice l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro -. Tra i vari fattori che aumentano il rischio di tumore (ricordando che esistono oltre cento tipi di tumori le cui cause non sono note) le abitudini alimentari giocano un ruolo, ma il nesso causale tra dieta e cancro è complesso e può essere difficilmente svelato. Certi alimenti possono essere più dannosi di altri, ma nessun prodotto può essere considerato buono o cattivo per la salute. Piuttosto, ogni prodotto deve essere valutato per i nutrienti che apporta nella razione alimentare giornaliera, tenendo a mente di non superare il limite quotidiano previsto in una dieta equilibrata”. E per quanto riguarda la carne rossa? “Un consumo eccessivo di carni rosse e soprattutto di carni rosse lavorate come salumi, insaccati e carne in scatola aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori. L’aumento è però proporzionale alla quantità e frequenza dei consumi, per cui gli esperti ritengono che un consumo modesto di carne rossa (una o due volte a settimana al massimo) sia accettabile anche per l’apporto di
nutrienti preziosi (soprattutto vitamina B12 e ferro), mentre le carni rosse lavorate andrebbero consumate solo saltuariamente”.
Meglio il burro dell’olio di palma?
Non c’è mamma che, potendo scegliere, preferisca un prodotto con olio di palma. I consumatori (soprattutto italiani) si sono uniti in un movimento di opinione senza precedenti, spingendo l’industria alimentare a fare retromarcia e a inventare una nuova categoria di prodotti, quelli “senza”. Cosa c’è di cattivo nell’olio di palma? Biscotti, merendine, creme spalmabili e dolci industriali, si sa, non sono il miglior nutrimento per i bambini. Fino a qualche tempo fa l’industria li produceva usando soprattutto olio di palma, un grasso “cattivo” accusato di essere cancerogeno, rovinare il sistema cardio-circolatorio e provocare una feroce deforestazione in Indonesia. L’attenzione su quest’olio è aumentata nel 2014, quando è cambiata la normativa europea sulle etichette. Il nuovo regolamento ha imposto di specificare sulla confezione i grassi utilizzati nelle preparazioni. Sono scomparse così le diciture vaghe, come “grassi vegetali” e l’olio di palma è uscito allo scoperto.
Per fare le merendine servono due ingredienti: grassi e zuccheri. I grassi migliori per dare consistenza ai prodotti sono quelli saturi, cioè “semisolidi”, come il burro. Tuttavia il burro e gli altri grassi di origine animale costano e non si conservano facilmente. All’industria servono grassi stabili, come le margarine industriali (i famosi grassi idrogenati, che uno stretto giro di vite dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha costretto ad abbandonare). Dovendo trovare un surrogato, l’industria ha scelto l’olio di palma, che ha una composizione molto simile al burro, con qualche vantaggio: quello raffinato è quasi insapore, non altera il gusto del prodotto finale, si conserva a lungo, è semisolido a temperatura ambiente, non irrancidisce e, soprattutto, costa poco. Fa davvero male? L’Italia è la patria dell’olio d’oliva, che contiene il 13% di grassi saturi. L’olio di palma ne contiene il 49%. L’olio di cocco, altro grasso diffuso nelle preparazioni industriali, arriva all’87%.
L’olio di palma raffinato perde le caratteristiche nutrizionali più interessanti (come i carotenoidi, gli antiossidanti, le vitamine) ma non i grassi saturi ed è dannoso esattamente come gli altri grassi, come il burro o lo strutto. Può essere consumato nella dieta quotidiana, ma in misura limitata. “Riflettiamo però sulla necessità di ridurre il consumo di prodotti da forno industriali – spiega Alessandra Bosetti, dietista clinica pediatrica -. È molto comodo volere le merendine e contemporaneamente la qualità nutrizionale. Proviamo a tornare a proposte più genuine, come pane e cioccolato, pane e formaggio, pane e pomodoro o pane e marmellata. Stiamo pagando un prezzo molto alto per aver accettato sulle nostre tavole nuovi prodotti alimentari comodi e a lunga conservabilità, ma di scarso valore nutrizionale. L’olio di palma non fa male in assoluto. A far male è l’abuso, il consumo sregolato e abituale, la scelta di cibo di bassa qualità”.
Senza glutine è meglio?
Una buona notizia: se non sei allergico, mangia tranquillamente il glutine. Ma non è l’unica notizia positiva: probabilmente non sei nemmeno allergico. Le statistiche dicono che l’1% della popolazione italiana è affetta da celiachia, tuttavia la moda dei cibi gluten free ha raggiunto un valore di mercato di 237 milioni di euro all’anno. Un bel business. Ci sono stelle del cinema come Gwyneth Paltrow che mostrano l’invidiabile forma fisica raggiunta dopo aver bandito il glutine. Ci sono supermercati che espongono scaffalature di prodotti nuovi rigorosamente senza glutine. E negozi, pasticcerie, ristoranti, blog che ci stanno convincendo che è più sano eliminare il glutine. Una vera ossessione alimentare, ma c’è qualcosa di vero?
Il glutine è una proteina contenuta in alcuni cereali: frumento, avena, orzo, segale, kamut e farro. In più si trova nella birra e in altri prodotti dell’industria alimentare. È assente nel riso, nel mais, nel miglio, nel sorgo, nel grano saraceno, nella quinoa e nell’amaranto. Il glutine, nelle persone geneticamente predisposte, è il “trigger” (il grilletto) che scatena la risposta degli anticorpi producendo una patologia, il morbo celiaco. Molti pensano di soffrire di problemi gastrici legati all’intolleranza al glutine, ma per diagnosticare l’allergia serve un medico, bisogna eseguire gli accertamenti diagnostici e stabilire con cura la dieta conseguente.
L’autodiagnosi fa solo male: non esiste una ragione scientifica che giustifichi l’eliminazione del glutine in individui che non siano affetti dal morbo celiaco o da una condizione definita di ipersensibilità. Al contrario, eliminarlo definitivamente rischia di impoverire l’alimentazione, rendendola monotona e impropria. Non è neppure vero che il consumo di prodotti senza glutine faccia perdere peso: i prodotti per celiaci, per motivi di tecnologia alimentare, spesso sono più ricchi di grassi rispetto agli omologhi con glutine. Non è vero neppure che togliere il glutine durante lo svezzamento influenzi il rischio di ammalarsi da grandi. “Introdurre il glutine a 12 mesi aiuta a prevenire la celiachia solo nei bambini ad alto rischio, geneticamente predisposti a non tollerare il glutine – scrive l’Associazione italiana celiachia (AIC) -. Ma a parte chi ha questa predisposizione, il glutine nella pappa non influisce sul rischio di ammalarsi, né influisce il momento in cui viene introdotto”.